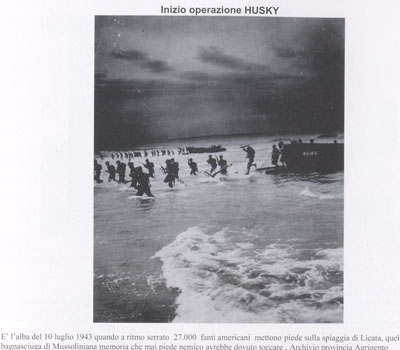Carissimo Stefano,
benvenuto a Mistretta. Ti farò da guida per mostrarti tutte le bellezze che Mistretta possiede.
Ti mostrerò la sua particolare struttura urbanistica, le stradine e i vicoli, le chiese, i palazzi signorili, le ville. Dalle parti più alte del paese ti farò ammirare le montagne, i monti boscosi, il mare Tirreno, le Isole Eolie. Ti accompagnerò alle famose Cascate incantate.
Parteciperai alle feste religiose di San Sebastiano, il patrono della città e della Madonna della Luce con i Giganti. Sicuramente trascorrerai un piacevole soggiorno.
Innanzitutto i racconterò un po’ della storia del suo glorioso passato.
CLICCA QUI
CLICCA QUI
Le origini di Mistretta sono antichissime, risalenti probabilmente all’età del bronzo.
Nella fascia occidentale della catena montuosa dei Nebrodi, insellata a 950 metri d’altezza, svetta Mistretta, una ridente cittadina che, per questa particolare forma di sella di cavallo, è soprannominata la “Sella dei Nebrodi“.

La città di Mistretta è posta a metà strada tra Palermo, dalla quale dista 120 Km, e Messina, la sua provincia, dalla quale dista 170 Km, distanze che si sono accorciate con l’apertura dell’autostrada A 20. Dista dalla costa tirrenica siciliana circa 12 km percorribili in breve tempo e, man mano che si scende verso Santo Stefano di Camastra, si ammira uno splendido paesaggio ricco di montagne, di mare e delle bellissime isole Eolie, le perle del mar Tirreno e che si fanno osservare soprattutto durante le giornate limpide.

Percorrendo la strada per Nicosia, dalla Sella del Contrasto, a 1120 metri di altezza, si ammira l’imponente cima del vulcano dell’Etna spesso innevata e sovrastata da una bianca nube. Le alte montagne che circondano il territorio sono rivestite dai folti boschi che, durante la stagione invernale, si coprono della candida neve.

Mistretta, estesa per una superficie di 127 Km2, è un’antica città che vanta una notevole ed intensa storia per aver subito tante civiltà che hanno lasciato testimonianze del loro passaggio visibili all’interno del centro storico.
Secondo l’archeologo, il prof. Vincenzo Tusa, la città fu edificata dai fenici, spinti da una tempesta nella sottostante costa tirrenica, i quali, sul monte della Vallata del torrente Santo Stefano, innalzarono il tempio dedicato alla dea Astarte, la divinità fenicia dei boschi, dalla quale la città prese il primo nome di “Am-Asthart o Meté Ashtart” ,popolo o uomini di Astarte.
Successivamente le sono stati assegnati i nomi: Amestratos, Mestraton, Mitistratos, Amastra, Mitistratum, Amestratus, come la città è citata negli scritti di Cicerone e di Stefano Bizantino e, in epoca medievale, fu denominata Mistretta.
Molto probabilmente, però, secondo lo storiografo Bordone Pagliaro, le sue origini risalgono ai Sicani, il primo popolo che abitò la parte orientale della Sicilia, e ai Siculi che sconfissero i Sicani. La loro presenza è stata dimostrata dalle antiche costruzioni in pietra e dagli oggetti di ceramica ritrovati nel territorio nei pressi della città molto simili ai reperti della civiltà sicana ritrovati nell’Asia Minore. Era gente che praticava la pastorizia e l’agricoltura e adorava la dea Cerere. Anche i Greci, Ioni e Dori, abitarono a Mistretta giungendo, intorno al 700 a.C,. sulla costa tirrenica siciliana e cominciando ad insediarsi verso l’interno. Si narra che un gruppo di greci, guidato dal condottiero Leukaspis, fu ben accolto a Mistretta tanto che lo stesso condottiero fu venerato come un dio.
I greci, a Mistretta, divennero sempre più numerosi e la città fu “ellenizzata” pacificamente.
La conseguenza della colonizzazione fu la civilizzazione degli abitanti del luogo.
Questo periodo fu fiorente per la Sicilia, anche per Mistretta, e produsse benessere e ricchezza. Presto furono innalzati templi (la Chiesa di San Giovanni Battista fu edificata sul tempio dedicato a Dioniso), furono allestiti ginnasi e teatri e fu avviata anche una necropoli per il culto dei morti.
La sua posizione geografica fece di Mistretta una fortezza inespugnabile, di cui hanno parlato Polibio e Tucidide, tanto che le aggressioni furono più volte respinte dalla frenetica opposizione dei cittadini. In epoca romana Mistretta ebbe tutti i privilegi comunali diventando “municipio” e centro di raccolta delle decime pagate da varie città durante la pretura dell’ingordo Verre. Marco TullioCicerone, nelle “Verrine“, narra dei soprusi commessi dal governatore Caio Verre ai danni di svariate città siciliane, tra le quali anche Mistretta, città sfruttata per l’enorme produzione di grano.
Tiberio Cazio AsconioSilio Italico, nelle sue “Storie“, descrisse Mistretta come un importantissimo centro che forniva ai romani oltre al grano, anche soldati ben addestrati. Per questo motivo apparteneva alle città federate che avevano il privilegio di pagare le tasse solo in minima parte compensando con uomini e con frumento. In effetti, Mistretta, con i romani, acquistò notevole importanza per la raccolta del suo frumento, prevalentemente di qualità dura, che facilmente si poteva conservare anche per lunghi periodi di tempo e per la sua posizione dominante divenendo punto di riferimento per chi viaggiava tra il cuore della Sicilia ed il Mar Tirreno.
Mistretta ha subìto alternativamente periodi di prosperità e periodi di crisi economica.
Sotto Cesare Augusto Mistretta, come moltissimi altri centri della Sicilia, iniziò ad impoverirsi e di essa non si ebbero più tracce storiche fino all’epoca imperiale, quando la popolazione riprese ad aumentare e a progredire nella pastorizia, nell’agricoltura e nel commercio.
Dopo il dominio dell’impero romano d’oriente, la conquista dei musulmani, guidati da Ibrahim Ibn Ahamed, rappresentò un momento di incontro con le culture e con le economie dell’Africa settentrionale. Fu la premessa per una nuova abbondanza per i mistrettesi perché i nuovi arrivati, mercanti e coltivatori, volevano valorizzare gli splendidi territori ereditati dai loro predecessori.
Dopo la caduta dell’impero romano, all’epoca delle invasioni barbariche, la Sicilia, e, quindi, anche Mistretta, fu preda dei Vandali, nel 468 d.C., e invasa dai Goti, da Teodorico, nel 491 d.C. Con la dominazione bizantina Mistretta ritornò ad acquisire i domini imperiali poiché i bizantini, al tempo di Giustiniano, nel 535 d.C., durante le guerre gotiche in Italia conquistarono l’intera Sicilia e ne fecero la loro base principale. Il predominio bizantino durò ininterrottamente per tre secoli e mezzo, dalla metà del VI fino all’IX secolo, e non fu favorevole all’isola sottoposta ad una dura dittatura militare e ad un intenso sfruttamento delle risorse.
Mistretta dovette sostenere una forte fiscalizzazione e il suo territorio fu sottoposto a ruberie e a saccheggi da parte islamica, tuttavia riuscì ad arricchirsi di opere d’arte. Meta di continue scorrerie saracene, l’isola fu conquistata dagli Arabi a partire dall’827 per merito della dinastia degli Aghlabiti d’Africa. Retta da un emiro, con capitale Palermo, gli Arabi fecero della Sicilia il loro epicentro commerciale nel Mediterraneo.
La conquista araba, anche se violenta, portò all’isola notevoli benefici. Gli Arabi incrementarono notevolmente l’agricoltura arricchendola di nuovi metodi e di altre forme di coltivazione. Furono loro ad introdurre le colture di arance, di limoni, di frutti squisiti come la pesca, l’albicocca, di ortaggi delicati come gli asparagi ed i carciofi. Importarono anche le coltivazioni del cotone, del carrubo, del riso, del pistacchio, delle melanzane. Persino il leggiadro e odorosissimo gelsomino e le spezie come lo zafferano, il garofano, la cannella, lo zenzero sono stati importati dagli Arabi.
Insegnarono a produrre le paste alimentari, il pane con la “guigiulena“, il sorbetto, “u turruni“, un dolce preparato con le mandorle tostate e amalgamate con lo zucchero. A Mistretta gli arabi dominarono la città tra l’827 e il 1070. Costruirono il nucleo originario del castello.
In seguito si insediarono i normanni che ristrutturarono e abbellirono l’originario castello edificato nel punto più alto della città.


Conosciuto già in epoca romana, Polibio definì il castello “vetustissimo”. Le prime notizie sulla fortezza si hanno da un privilegio del 1101 con il quale il conte Ruggendo donò Mistretta e il suo castello al Demanio Regio. Le macerie dell’antica fortezza sono riconoscibili nella campagna antistante il monte castello presso il quale alcuni scavi hanno portato alla luce reperti archeologici di grande valore storico come le monete.

Dal castello ebbe inizio il primo fulcro del paese. Dalle pendici della montagna le primitive piccole abitazioni, dai tetti muschiosi e rossicci, abbracciate le une alle altre, separate da strette, tortuose e accidentate stradine, estendendosi a poco a poco, costituirono il primo nucleo abitativo del popolo amastratino che, tranquillamente, cominciò la vita dedicandosi al lavoro nei campi, nei boschi e alla pastorizia.

Il lungo dominio arabo è testimoniato dai numerosi termini dialettali, dalle diverse usanze ricorrenti nell’artigianato, nell’agricoltura, nel commercio e dalla toponomastica di alcuni agglomerati urbani del centro storico. Il centro dell’amministrazione era, allora, la “rabbica araba”, sita in via Canova, una costruzione con due ampi balconi a semicerchio e che serviva per la raccolta del grano.

I Siciliani subirono la dominazione araba, ma non l’accettarono e non si rassegnarono mai, come lo provarono le cinque successive insurrezioni del 849, del 912, del 936, del 989, del 1038 che fecero traballare la potenza musulmana. Nel sentimento e nel linguaggio popolare gli Arabi detti “Saraceni“, dal nome di una loro tribù, erano considerati nemici. Alla dominazione araba successe la dominazione normanna.Verso la metà dell’XI secolo, alla fine di un periodo di lotte tra signori arabi, fu chiesto l’intervento dei Normanni, da “North-man” “uomo del nord” che, venuti a gruppi, si insediarono nell’Italia meridionale. I normanni furono presenti dal 1060 al 1195. Il gruppo che si era distinto per il numero di uomini e per l’abilità militare fu quello guidato dalla famiglia degli Altavilla alla quale appartenevano i fratelli Roberto il Guiscardo e Ruggero. Roberto il Guiscardo operò nell’Italia meridionale e formò il ducato di Puglia e di Calabria. Ruggero, conquistata tutta la Sicilia, costituì la “Contea di Sicilia” sostenuto dai papi che attribuirono ai prìncipi normanni il titolo di legati apostolici. Alla morte di Ruggero, avvenuta nel 1130, gli succedette il figlio Ruggero II che unì la Sicilia ai possessi normanni dell’Italia meridionale perché si era estinta la dinastia di Roberto il Guiscardo, ottenendo il titolo di Re di Sicilia e di Puglia. Ruggero II riorganizzò l’amministrazione dell’isola dandole un saldo potere centrale e facendone il fulcro della potenza mediterranea della stirpe normanna. Creò un regno assai prospero riuscendo, con una saggia tolleranza religiosa, a conciliare la fede araba con quella cristiana. Da allora il regno normanno di Sicilia ebbe parte di primo piano sia nei conflitti tra il Papato e l’Impero, appoggiando la causa guelfa, sia nelle vicende mediterranee e nella lotta contro i Turchi. A Ruggero II successe la figlia Costanza andata in sposa, nel 1186, ad Enrico VI, il figlio di Federico Barbarossa. Nel 1190 Enrico VI, alla morte del padre, fu eletto imperatore del Sacro Impero Germanico (Regno di Germania e Regno d’Italia) e Re di Sicilia. La conquista normanna sostenne a Mistretta la nascita di un nuovo borgo che si strutturò a cerchi concentrici attorno e fino alle falde del castello.
Una possente cinta muraria, con torri e con almeno quattro porte ortogonali: porta Palermo, porta Messina, porta della Piazza, poi del “Muru ruttu”, e Pusterla, di cui è ancora in situ solo porta Palermo, difendeva l’ingresso e l’uscita della città. Un terzo nucleo fu quello costituito dal quartiere ebraico inizialmente isolato ed equidistante dagli altri due. Con i Normanni, i grandi latifondi, divisi dagli Arabi, si ricostituirono e si rafforzò ancora di più il baronaggio.
Il conte Ruggero d’Altavilla fece ampliare ancora il castello di Mistretta, di cui oggi rimangono solo pochi ruderi che sovrastano la città, che fu più volte al centro di operazioni militari.
Nel 1082 Giordano, il figlio illegittimo di Ruggero, approfittando dell’assenza del padre che si era recato in Calabria, tentò di usurpargli il potere con la complicità di alcuni cortigiani. Ruggero d’Altavilla, nel 1101, donò Mistretta in feudo, con tutti i suoi splendori e con tutto il suo territorio, al fratello Roberto, Abate del Monastero della Santissima Trinità in Mileto Calabro. Dall’atto di donazione emergono notizie storiche sul paese che in quel periodo si stava ampliando estendendosi lungo i fianchi del monte del castello e dentro le mura di difesa.
I resti sono visibili nel Vico Torrione e lungo la Strada Numea, esattamente dove si apre la Porta Palermo, una delle due antiche porte della città.
Oltre all’insediamento urbano circondato dalle mura, vi erano numerosi “bagli“, aggregati sociali e produttivi circondati da orti.
Proprio a partire dagli antichi “bagli” si sono formati i quartieri medioevali di Mistretta che si possono ammirare ancora oggi nell’attuale tessuto urbano del centro storico.

Il centro della città conserva ancora oggi il suo primitivo impianto di origine medievale, anche se nel suo tessuto si sono armonicamente fuse costruzioni rinascimentali, barocche, liberty con l’uso di pregevole materiale edilizio e con la perizia e l’abilità delle maestranze locali.
Un altro avvenimento storico del 1160 riguarda la cessione del territorio da parte di Guglielmo il Malo a Matteo Bonello che, ottenuta l’investitura della città, si fece promotore del complotto contro il re e che si concluse con l’uccisione del ministro Maione di Bari.
Con Enrico VI ebbe inizio la dominazione sveva durante la quale la Sicilia fu al centro delle trame politiche e diplomatiche dell’Europa. Egli voleva completare i grandi progetti del padre, ma non ebbe neanche il tempo di iniziare perché la morte lo colse a Messina dopo pochi anni di regno.
Assunse la reggenza dell’Impero la Regina Costanza, ma la morte colse anche lei dopo che ebbe affidato al papa Innocenzo III la reggenza del Regno e la protezione del figlio
. Sotto l’impero di Federico II di Svevia, (1197-1250), la città di Mistretta, nel 1233, occupava il XXXII posto al Parlamento Siciliano con il titolo di “Urbis imperialis”, qualifica che mantenne per molto tempo. Successivamente fu assoggettata a Federico d’Antiochia e poi a suo figlio Corrado.
In questo periodo fu realizzato l’attuale stemma della città di Mistretta raffigurante un’aquila imperiale con la croce in petto, ad ali aperte, con la testa rivolta a destra, su uno scudo sorretto da due ramoscelli di quercia e di alloro, il tutto sottostante ad una corona simbolo di potenza e di redenzione. E’ lo stemma degli Hohenstaufen nel Regno di Sicilia.


Alla dominazione sveva successe l’occupazione angioina che fu una vera e propria dominazione militare.
Carlo I d’Angiò impose alla Sicilia un tipo di feudalesimo che danneggiò l’economia di molti centri, tra cui anche la città di Mistretta che fondava la sua economia sull’agricoltura e sul commercio. Le prevaricazioni francesi, le prepotenze dei feudatari, la mancanza di sensibilità verso i problemi del popolo e i soprusi operati dalla classe dirigente avevano reso ostile l’intera popolazione e provocarono la guerra dei Vespri, o i “Vespri Siciliani“, nel 1282, conclusa con l’intervento di Pietro d’Aragona che aveva sposato Costanza, la figlia di Manfredi, e avanzava, pertanto, alcuni diritti sul Regno di Sicilia.
Gli Angioini ripristinarono la politica del latifondo, tipica dei romani, ma soppressa dagli arabi, ed affermarono lo strapotere dei feudatari. Impoverita dagli insostenibili prelievi fiscali, anche la città di Mistretta insorse contro gli Angioini e, nel 1282, i mistrettesi si unirono alla rivolta partecipando anche loro ai “Vespri Siciliani”. I mistrettesi si levarono contro i francesi che impedivano il commercio del legname dei propri boschi, del carbone e dei prodotti della pastorizia. La piazza davanti alla chiesa di San Giovanni si chiama “Piazza dei Vespri” appunto per ricordare che quello fu il luogo dove si radunarono i rivoltosi armati. Per il prezioso contributo apportato nella lotta contro i francesi, la città fu inserita tra quelle demaniali ed accolta nel Parlamento del Regno di Sicilia con capitale Palermo. La guerra durò venti anni e terminò con la pace di Caltabellotta nel 1302.
La Sicilia fu così affidata agli Aragonesi.
La signoria feudale su Mistretta continuò in età aragonese dal 1285 al 1415. Diversi sono stati i feudatari tra cui bisogna ricordare Gregorio Castelli, conte di Gagliano, a cui la città di Mistretta fu ceduta dal re Filippo IV che, spinto dall’esigenza di avere del denaro necessario per sostenere le spese della guerra in Italia, gliela vendette per la modica somma di 80.000 scudi.
Il popolo amastratino, al prezzo di enormi sacrifici, riscattò la città e saccheggiò il castello divenuto il simbolo di un potere sgradito.
Nel 1447 il regime del re Alfonso d’Aragona segnò un momento storico di splendore per la città. Mistretta conseguì il titolo di “Città demaniale”.
Il ceto artigiano, entrato a far parte del governo della città, si adoperò a far fiorire le lettere e le arti con la costruzione di molti palazzi gentilizi e chiese. Cominciò, finalmente, una lenta ma progressiva ripresa economica.
E gli anni passavano!
Il Settecento fu un periodo di floridezza economica per i mistrettesi dovuta allo sfruttamento dei materiali boschivi e alla commercializzazione dei prodotti agricoli perché, per la sua posizione geografica, Mistretta fu luogo di passaggio per mercanti e per soldati poiché univa il massiccio centrale della Sicilia alle coste del Mar Tirreno.
La presenza di una classe borghese agiata consentì il fiorire di attività artigianali le cui maestranze furono molto brave nel saper lavorare la pietra, il ferro e il legno. L’epoca spagnola si protrasse per circa due secoli e mezzo a conclusione del periodo di guerre europee suggellato dalla pace di Utrecht nel 1713.
Nel 1713, secondo il Trattato di Utrecht, la Sicilia toccò a Carlo VII del Sacro Romano Impero e, successivamente, a Carlo III di Borbone e, come regno nuovamente indipendente, a Vittorio Amedeo II di Savoia.
Cinque anni dopo, con il trattato di Cockpit, l’isola fu consegnata agli Asburgo d’Austria. Si aprì un’altra breve fase contrassegnata dal pesante fiscalismo austriaco e dai contrasti con il personale spagnolo e chiuso con la guerra di successione polacca quando Carlo III di Borbone riportò la Sicilia sotto il dominio spagnolo. L’arrivo del nuovo sovrano in Sicilia fu accolto con molto entusiasmo, ma tale clima si placò visto che la permanenza siciliana di Carlo III durò solo pochi giorni. La Sicilia perdette parte del fasto ottenuto durante la dominazione normanna, sveva ed aragonese ed assunse un ruolo marginale nella politica europea. Questo fu anche il periodo di quel processo riformatore con il quale si voleva abbattere il forte potere baronale e sminuire il vecchio ordinamento feudale ancora presente in Sicilia. Arrivarono i borboni.
Durante la dominazione borbonica Mistretta fu totalmente amministrata dai baroni locali. La borghesia locale si preoccupò di abbellire e di ampliare la città oltre le mura e, per questo motivo, fu urbanizzata l’area attorno alla Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria. Furono costruiti altri palazzi, furono arricchite le chiese con numerose opere d’arte, fu aperta la biblioteca comunale. La Chiesa Madre costituì il fulcro dell’espansione di numerosi quartieri. Nello stesso periodo furono edificati l’Ospedale e la Casa dei Pellegrini. La presenza a Mistretta, alla fine del 1800, dell’Architetto Basile, progettista anche del cimitero monumentale, influenzò il nuovo assetto urbanistico con la costruzione di fontane, di larghi, di piazze e fu ampliata la villa comunale “Giuseppe Garibaldi”.

Altri personaggi che hanno saputo abbellire la città sono stati: l’architetto Silvestre Marciante e lo scultore Noè Marullo.


La città riacquistò l’antica importanza e divenne il punto di riferimento commerciale e culturale anche dei centri vicini. Il regime poliziesco di Ferdinando II, detto Francischiello perchè dotato di intelligenza limitata e di scarsa energia, cheabolì ogni forma di autonomia dell’isola, che non volle concedere riforme liberali, che manifestò il disprezzo verso la cultura, che derideva i letterati definendoli “pennaioli“, che accrebbe il malcontento generale diffusosi tra i siciliani e il popolo amastratino, soprattutto presso la nascente classe media costituita da professionisti, da artigiani, da massari, fece sì che Mistretta fosse una delle prime città ad insorgere contro i borboni.Tra i siciliani che più calorosamente si adoperarono per la loro terra furono Francesco Crispi, (Ribera, 4 ottobre 1818 – Napoli, 12 agosto 1901), e Rosolino Pilo, (Palermo, 15 luglio 1820 – San Martino delle Scale, 21 maggio 1860). Giuseppe Garibaldi, sollecitato a venire in aiuto della Sicilia, si dichiarò pronto ad intervenire con una spedizione di volontari se sull’isola fosse scoppiata la rivoluzione.

Il 4 aprile del 1860 la rivolta scoppiò a Palermo, presso il monastero della Gancia. Nelle campagne perdurava la guerriglia guidata da Rosolino Pilo il quale aveva confermato il prossimo intervento di Garibaldi. La situazione precipitò e le forze borboniche non riuscirono a fronteggiare il movimento popolare. Anche Mistretta diede il suo contributo alla lotta per l’Unità d’Italia di cui si festeggiano quest’anno i 150 anni.
E’stata innalzata la bandiera tricolore sul castello.


All’interno del palazzo di città è esposta la lapide

Nella facciata del palazzo di città di Mistretta, lateralmente al portone d’ingresso, due lapidi commemorative ricordano personaggi che si sono distinti per particolari azioni politiche. In una di esse si legge: ” Pietro Daidone, muratore, nella notte dell’8 Aprile 1860 inalberò sul castello il Tricolore che atterrato dalla polizia borbonica Egidio Ortolani Delmo, calzolaio, issò la sera del 10. Data dell’istallazione della lapide il 13-5-1960”.

Fra le personalità amastratine che si adoperarono per la causa nazionale si devono ricordare: il sac. Giuseppe Salamone, il frate Vincenzo da Catania, il sac. Giuseppe Marciante. All’alba del 5 maggio del 1860 partì la spedizione dei Mille. Due vaporetti, Lombardo e Piemonte, salparono dallo scoglio di Quarto con poco più di 1000 uomini, che indossavano la camicia rossa, comandati dal generale Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi e Nino Bixio comandavano le due navi. L’11 maggio i due vaporetti giunsero a Marsala e, da Marsala, Garibaldi si diresse verso Salemi dove lanciò un proclama ai siciliani e dove fu proclamato dittatore della Sicilia con le parole d’ordine “Italia e Vittorio Emanuele”.
Garibaldi puntò su Palermo, ma un esercito borbonico, accampato sulle alture di Calatafimi, gli sbarrò la strada. La battaglia fu lunga ed aspra. La vetta del colle di Calatafimi fu conquistata mentre i borboni si ritiravano su Palermo. La battaglia per la conquista di Palermo durò quattro giorni. Vi parteciparono anche i mistrettesi. Nell’altra lapide, esposta nella facciata del Palazzo di città, si legge: ”Partecipò all’epopea garibaldina un drappello d’armati mistrettesi che sotto il capo guerriglia Domenico Cardinali entrando in Palermo il 27 maggio 1860 pagavano il loro tributo di sangue. Data d’istallazione della lapide il 13-5-1960”.

Il 30 maggio i soldati borbonici, asserragliati in città, chiesero l’armistizio; il 6 giugno sgomberarono Palermo. Garibaldi formò un governo provvisorio con a capo Francesco Crispi mentre la rivolta si era estesa a tutta l’isola. Nuove schiere di volontari accorrevano dal Continente e dalle province. Il 20 luglio i Mille sconfissero definitivamente i Borboni nella battaglia di Milazzo e, nei giorni successivi, ottennero la resa di Messina, avendo così il passaggio aperto per continuare le battaglie contro il Regno delle Due Sicilie nel continente. Molti siciliani si arruolarono nell’Esercito meridionale di Garibaldi. La Sicilia, conquistata per intero, fu pronta per l’annessione al Piemonte.
I modi in cui avvenne l’assimilazione della Sicilia al Piemonte, entrando a far parte del Regno d’Italia, dopo la spedizione garibaldina dei Mille, frustarono nuovamente le attese autonomistiche dell’isola la cui economia a base feudale e latifondista non fu in grado di risollevarsi in conseguenza dell’unificazione venendo anzi a costituire una componente sostanziale della cosiddetta “questione meridionale”, la disastrosa situazione economica e sociale del Mezzogiorno in confronto alle altre regioni dell’Italia unificata. Intanto gran parte dell’aristocrazia locale, che mal aveva sopportato il regime borbonico, sicuramente aspettava il momento favorevole per modificare l’ordine esistente nell’intento di ricavare benefici economici.
Il popolo mistrettese che versava in condizioni precarie, nella rivoluzione vide l’occasione per conseguire miglioramenti sociali, per avere maggiore giustizia e per poter disporre della terra. L’ordine pubblico non esistette più, le autorità borboniche scomparvero, molti si fecero giustizia da sé, i furti e le estorsioni erano in continuo aumento.
Nacque un “Comitato per il governo di questo comune“ nominato dal popolo. Peculiare caratteristica fu la preoccupazione di salvaguardare la proprietà privata con l’ausilio di una organizzazione di pubblica sicurezza. All’inizio del 1900 Mistretta si preoccupò di fare migliorare il livello economico, artigianale, artistico e culturale ma, dietro alla costruzione dei palazzi nobiliari, alla nascita dei circoli culturali, alle feste di paese, si celavano ancora le sorti infauste che segnarono la storia della Sicilia dopo l’unità d’Italia.
L’abolizione degli usi e delle terre comuni, le tasse gravanti sulla popolazione, il regime di occupazione militare, la mancanza di lavoro, che non riusciva a sfamare la popolazione a causa di una economia asfittica, crearono nel meridione un forte malcontento che sfociò nel brigantaggio, nella mafia e nell’emigrazione verso gli Stati Uniti, il Brasile e l’Argentina.
Le statistiche affermano che tra il 1871 e il 1921 quasi un milione di siciliani si allontanarono dalla Sicilia. Tramite i registri di sbarco di New Jork, dove venivano annotati i nomi degli emigrati, è stato calcolato che, nell’arco di tempo che va dal 1897 al 1924, sbarcarono nella metropoli americana ben 3714 nativi di Mistretta. Anche mio nonno materno fu coinvolto dal flusso dell’emigrazione all’estero. Il nonno Salvatore Lorello (Mistretta 25/12/1886 – Mistretta 25/02/ 1966), sposatosi con la signora Anna Spinnato il 20 ottobre del 1908, subito dopo la nascita del primo figlio Filippo, avvenuta a Mistretta il 15/12/1009, partì per l’America. Là nacque Charles, il secondogenito.
La famiglia, ritornata in Italia perché le condizioni climatiche erano sfavorevoli alla vita della donna, si accrebbe nel numero con la nascita di altri tre figli. Maria Grazia, mia mamma, Antonino e Alberto morto in tenerissima età.
Il giovane Charles all’età di 16 anni sentì la necessità di ritornare in America.
Partì da solo. Il lungo viaggio nell’immenso mare, durato un mese, le frequenti tempeste, che minacciarono la vita di tutti i viaggiatori, lo stress psicologico lo scoraggiarono a tal punto da impedirgli di ritornare in Italia magari per un viaggio turistico.
Non è ritornato mai più.
Il rapporto con la famiglia è stato soltanto epistolare. Filippo Lorello, richiamato dal fratello Charles, partì per gli Stati Uniti nel 1967 con la moglie, la signora Lucia Porrello, e con tre figlie: Graziella, Pippa e Liria.
Altri tre figli: Annina, Totò e Nino sono rimasti in Italia. Dopo un quinquennio di permanenza in terra lontana, Filippo ritornò con la moglie Lucia a Mistretta. Le sue ossa riposano nel cimitero monumentale di Mistretta dal 30/04/1978. In America sono rimaste le figlie Pippa e Liria, che vivono in America, Graziella è deceduta da molti anni. Una famiglia unita dall’amore, ma divisa dall’emigrazione.
Lo scoppio della prima guerra mondiale, della “Grande Guerra”, avvenuto il 28 luglio 1914, che richiamò alle armi i giovani siciliani, smembrò gli affetti familiari, lasciò nell’incuria i campi, privò i parenti di ogni mantenimento.
Il conflitto si concluse quattro anni dopo, l’11 novembre del 1918.
Al termine della prima guerra mondiale, da un’eterogenea commistione di arditi, di sindacalisti, di rivoluzionari, di futuristi, di nazionalisti, il 29 ottobre del 1922 nacque il movimento politico chiamato “Fascismo” che durò circa un ventennio. Il Fascismo ebbe un ruolo molto importante nelle vicende del Mezzogiorno. Lo stato fascista, ansioso di allargare il proprio consenso e interessato ad una crescita economica che sostenesse la sua politica espansionista, prese seriamente in carico il problema dello sviluppo del Meridione.
In quel periodo anche mio padre Giovanni Seminara, (Mistretta 24/06/1009 – Mistretta 2/05/1990), ha dato il suo piccolo contributo all’Italia. Apparteneva all’Arma dei Carabinieri. Andò a Trieste, a Caporetto e a Fiume. In una lettera indirizzata alla mamma scrisse: Cara mamma il giorno 15 Aprile del 1929 fui promosso carabiniere. Voi non potete immaginare quale gioia io provassi per tale promozione. Dopo sei lunghi mesi di istruzione, ecco finalmente raggiunto lo scopo. Il primo ambìto desiderio è perciò raggiunto con tutta soddisfazione.
Vi assicuro che compierò sempre il mio dovere non solo ma spero con qualche sacrificio e con lo studio di poter migliorare la mia posizione e continuerò senz’altro nella mia carriera. Sono ora in attesa di essere destinato alla nuova legione. Vi terrò infornata della mia partenza e vi farò conoscere appena possibile la mia nuova residenza. Vi giungano intanto affettuosi saluti dal vostro aff.mo figlio Giovanni”.



Il 19 luglio del 1943 segnò un altro importante momento storico. Iniziò la seconda guerra mondiale. Dal balcone di Piazza Venezia Mussolini annunciò: “Un’ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra Patria, l’ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli Ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. […] La parola d’ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti: essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all’Oceano indiano: vincere! E vinceremo”!
La guerra ha interessato la mia famiglia paterna. Lo zio Vincenzino Seminara, (Mistretta 11/11/1913- Mistretta 5/04/ 1974), fratello di mio padre, fu prigioniero in Albania. Un militare, arrivato a Mistretta a piedi e con mezzi di fortuna, portò la notizia che Vincenzino si era fermato a Santo Stefano di Camastra perché, stremato, non aveva più la forza per continuare a camminare. Mio padre, dopo aver chiesto in prestito al cav. Enzo Tita il calesse, con tale mezzo, sul quale fece salire la madre, la sorella Maria, mia madre ed io bambina, partì alla volta di Santo Stefano di Camastra per andare a recuperare il fratello che tornava dalla guerra. Era scarno, sporco, affamato.
Spesso a noi nipoti, che amava tanto, parlava della guerra, descriveva i disagi e la fame. Raccontava che assieme agli altri militari andava a rovistare nella spazzatura nella speranza di trovare le bucce delle patate con le quali potere smorzare i morsi della fame.
Il fratello Giuseppe Seminara, lo zio Peppino, (Mistretta 13/02/1919), non ha fatto mai più ritorno in Patria.
E’ stato dichiarato disperso in Russia il 14/11/1951.


La lettera alla sua mamma, la signora Sebastiana Isabella:

Sua madre, mia nonna, lo ha atteso invano. Fino al 1946 l’Italia era una monarchia costituzionale basata sullo Statuto albertino. Dopo la seconda guerra mondiale il 18 giugno del 1946 nacque la Repubblica Italiana. Si trattò di un passaggio di evidente importanza per la storia dell’Italia contemporanea dopo il ventennio fascista ed il coinvolgimento nella seconda guerra mondiale.
La transizione si svolse in un clima di esasperata tensione e rappresentò un controverso momento della storia nazionale assai ricco di eventi, di cause, di effetti e di conseguenze, registrate anche a Mistretta, ed è stata considerata una rivoluzione pacifica dalla quale derivò una forma di stato poco differente da quello attuale.
Il 10 giugno, alle ore 18,00, nella Sala della Lupa a Montecitorio, la Corte di Cassazione lesse i risultati del referendum inviati dalle prefetture.
I voti favorevoli alla repubblica furono 12.717.923, mentre quelli favorevoli alla monarchia furono 10.719.284.
La nascita della Repubblica fu accompagnata da polemiche di una certa consistenza circa la regolarità del referendum che la sancì. Da questo momento, molto lentamente ricominciò lo sviluppo sociale ed economico dell’Italia.
Negli anni ‘60 e ‘70 le aree industrializzate del Nord dell’Italia vissero un periodo di sviluppo economico, chiamato miracolo “italiano”, incentrato sull’esportazione di prodotti finiti.
Il fenomeno importò dal Meridione altra manodopera. L’emigrazione, per combattere la disoccupazione, provocò un grave danno a tutta la Sicilia che assistette allo svuotamento dei suoi paesi. Pure Mistretta riscontrò questo problema, anche se riuscì a mantenere un certo numero di abitanti evitando il dannoso spopolamento del paese grazie alla “salvaguardia” delle attività agro-silvo-pastorali.
Nell’Ottocento Mistretta contava circa 20.000 abitanti, ma, secondo l’ultimo censimento, registra 5076 abitanti di cui 2372 maschi e 2704 donne.
Attualmente questi numeri sono ancora diminiuti.
In mezzo secolo Mistretta ha subìto la fuga di tanti nuclei familiari e di tanti giovani che, per motivi di studio e di lavoro, si sono allontanati dal centro nebrodeo alla ricerca di migliori condizioni di lavoro. Da sempre la pastorizia e l’agricoltura sono state le attività prevalenti a Mistretta.
In molti documenti degli antichi romani è menzionata come una delle più fertili città della Sicilia e considerata il granaio di Roma.
L’economia cittadina, purtroppo molto magra, si basa, tuttora, principalmente sulla pastorizia e sull’agricoltura con la coltivazione di oliveti, di vigneti, di agrumeti, di orti.
Pascolano armenti, un tempo assai numerosi, che danno una buona produzione di prodotti caseari di indiscussa qualità e genuinità. Tuttavia, oggi il mondo agricolo-pastorale, prima binomio di forza dell’economia locale, oggi è attanagliato da una certa crisi economica per la stesura di leggi europee che impongono l’adozione di moderne tecnologie.
Gli allevamenti producono carni pregiate e formaggi ritenuti tra i migliori della Sicilia, ma sottoposti a rigide regole di mercato. I boschi assumono una grande rilevanza soprattutto sul paesaggio montano purtroppo deturpato dalle ingombranti pale eoliche che non si armonizzano per nulla con l’ambiente.

Anche l’artigianato locale, che prima abbracciava settori fiorenti come quello dei fabbri, dei falegnami, degli scultori della pietra, che tanto hanno impreziosito gli edifici cittadini con le loro opere, oggi si sono notevolmente ridotti. Le poche botteghe artigiane presenti a Mistretta sono a conduzione familiare. Non esistono industrie. Da una montagna si estrae una pietra dura rosata che, per il suo particolare colore, prende il nome di “pietra dorata”, ma che ha modificato la naturale forma della montagna.
Sono stati soppressi il Tribunale nel settembre 2013, il carcere nel 2014, è stato depotenziato l’ospedale a causa della Spending Review.
Le scuole hanno ridotTo il numero degli alunni. Un’importante fonte di reddito per l’economia cittadina potrebbe essere l’incremento del turismo incoraggiato dall’importante patrimonio storico e artistico, dalla suggestiva bellezza del paesaggio boschivo, dall’attrazione delle numerose feste folcloristiche locali, dalla degustazione dei prodotti locali.
Caro Stefano, dopo averti raccontato la sua storia, adesso ti descrivo Mistretta che possiede un patrimonio naturale a volte aspro e selvaggio composto di un’infinità di luoghi d’eccezionale interesse paesaggistico – ambientale di straordinaria bellezza.
Flora, fauna, mare, monti, fiumi danno un quadro pressoché completo al territorio. Le alte montagne, 1503 metri il monte Castelli, 1120 metri la Sella del Contrasto e, nelle vicinanze, 1847 metri il monte Soro, diventano ancora più suggestive sotto la coltre della candida neve.

I ripidi pendii, fino a valle, sono rivestiti dai boschi nebrodensi fitti e rigogliosi. Querce, lecci, faggi, olmi, frassini, cerri, castagni, e il raro Abies nebrodensis

formano una ricca flora che ospita conigli, volpi, donnole, istrici, lepri, rettili, anfibi, uccelli, invertebrati e regalando abbondanti funghi mangerecci raccolti durante le piacevoli escursioni.
Nel laghetto “Urio Quattrocchi”, ai piedi del monte Castelli, la Natura ancora incontaminata mostra un’atmosfera primitiva, pacifica, silenziosa. Là si sente palpitare la vita tra le diverse piante acquatiche, è numerosa la fauna selvatica ed è probabile incontrare la graziosa tartaruga palustre. Sui Nebrodi è tornato a volare il grifone introdotto dalla Spagna.

Inoltre nella ricca vegetazione del laghetto “Urio Quattrocchi” spuntano tantissime varietà di funghi che io preferisco fotografare e non mangiare.




Il boschetto “La Neviera”, sulla strada per Castel di Lucio, incoraggia a piacevoli passeggiate a piedi lungo i sentieri e a soste con amici per i picnic.
La villa comunale “Giuseppe Garibaldi”, una macchia verde nel centro del paese, ospita numerose ed importanti essenze vegetali provenienti da diverse parti del mondo.

Sostare dentro la villa è trascorrere momenti di osservazione, di distensione, di piacevole conversazione. La visita del paese deve necessariamente cominciare dal castello, primo fulcro dell’insediamento urbano da dove le case, costruite con la locale pietra ocra – rosata- dorata, addossate l’una all’altra, danno una pittorica uniformità cromatica.
Il centro storico è formato da un dedalo di viuzze “vanedde” che si intersecano interrotte di tanto in tanto da piccoli slarghi. Molte sono le chiese, grandi e piccole, anche rurali, a testimonianza dell’intensa religiosità popolare. Sono proprio queste che individuano i quartieri cittadini. Sono le chiese di: San Nicola, San Pietro, Santa Caterina, San Biagio, Santa Rosa, Santa Maria, SS. Rosario, San Giuseppe, San Vincenzo, San Cosimo e Damiano, Madonna del Carmelo, San Francesco, Madonna dei Miracoli, Sant’Antonio, l’Annunziata, Madre Tagliavia, Matri Rivinusa. Sulla colonna stile corinzio del portale della Chiesa Madre è scolpita l’aquila sveva, dalle ali ampiamente distese nell’impeto gagliardo di volare, stemma di Mistretta e simbolo di potenza e di vittoria.

All’interno della chiesa la statua marmorea della Madonna dei Miracoli ricorda la scuola gaginiana.

La Chiesa di San Sebastiano, patrono della città, custodisce il prezioso fercolo ligneo barocco cupuliforme con la statua del Santo realizzata dall’artista amastratino Noè Marullo nel 1906.

Alla Chiesa di San Giovanni si accede mediante due scalinate laterali, curvate che la raccordano alla piazza dei Vespri e conferiscono all’insieme un notevole aspetto scenografico arricchito dai leoni di pietra posti lateralmente all’ingresso della porta principale.
I palazzi signorili mostrano le decorazioni a rilievo in pietra intagliata da maestranze locali.

Le figure allegoriche e le divertenti e grottesche maschere hanno la funzione magica di allontanare o annullare, con il linguaggio figurativo, le influenze malefiche dai loro padroni.

Le stesse propiziano abilmente il benessere, la bellezza per la vita delle personalità che abitavano realmente nel palazzo.
Altre maschere manifestano atteggiamenti di gioia, di collera, di meraviglia, di stupore, di abbondanza.

Rappresentano, inoltre, l’allegoria della cultura che era un privilegio della classe nobile e della nuova aristocrazia e, riproposte in bassorilievo sul portale della Chiesa Madre e della Chiesa di Maria SS.ma del Rosario, sono simbolo di corruzione e di frivolezza.

Caratteristici sono anche tutti i lavori in ferro battuto delle ringhiere dei balconi. L’itinerario deve continuare con la visita al Museo delle Tradizioni Silvo – Pastorali, al Museo della Fauna e dello Scòpennino, al Museo civico, alla Biblioteca comunale, questi ultimi ospitati presso il palazzo della cultura Mastrogiovanni –Tasca, e al Cimitero Monumentale nelle cui cappelle gentilizie si legge l’estro artistico dell’architetto Giovan Battista Basile. Adiacente al cimitero è la chiesa della Madonna della Luce. Il suo simulacro è accompagnato, durante la festa, da due giganti “ i Gesanti”, Cronos e Mitia, figure di guerrieri ritenuti i fondatori della città.


Altri scorci visitabili sono rappresentati da archi, da scale esterne, da anditi, da ballatoi, da balaustre. Luoghi d’incontro e di vita sociale sono: la Piazza Unità d’Italia e le sedi delle Società di mutuo soccorso dove i mistrettesi si raccolgono in gruppi, si scambiano le opinioni, gli auguri, i saluti!
A Mistretta anche il clima è gradevole. Ogni stagione dell’anno riserva magnifiche sorprese e mostra bellissimi paesaggi naturali.
In primavera c’è il risveglio della Natura e le piante perenni escono dal lungo letargo invernale per riprendere il nuovo ciclo vegetativo.
E’ particolarmente affascinante per l’esplosione di colori e di fiori, ma ha il torto di essere breve e non dà la possibilità di gioire dell’incanto della Natura che sboccia a nuova vita. La nebbia, presente molto spesso, offusca il paesaggio. L’estate mite della montagna favorisce sì lo sbocciare dei fiori, i cui colori si mescolano bene come nella tavolozza del pittore, fa respirare un’aria fresca, ossigenata e salubre, ma è poco durevole.
In autunno comincia il declino perchè alcune piante annuali hanno completato il loro ciclo riproduttivo. Arriva quasi all’improvviso, regala le tonalità pastello del rosso e del giallo delle foglie, ma non ha il tempo di inserirsi che è quasi subito sostituito dai rigori invernali. In inverno è emozionante osservare le curiose ramificazioni degli alti alberi di pini, di cedri, di abeti ricoperte di neve, suggestivo fenomeno che si osserva più raramente viste le mutate condizioni climatiche.
Caro Stefano,venendo a visitare Mistretta hai trovato una meritevole accoglienza nel sorriso dei residenti, nella cordialità, nell’affabilità, nel fascino di un’ospitalità, in una cultura antica e in una natura stupenda e incontaminata.
 Senza categoria
Senza categoria  Comments Off on LA CLEMATIS SUPERBA
Comments Off on LA CLEMATIS SUPERBA  Il frutto è composto da numerosi acheni sormontati da un’appendice piumosa per favorire la disseminazione. Ogni frutto ha un solo seme. La riproduzione avviene per semina, per talea e per propaggine. La pianta di Clematide necessita di un terreno ricco di humus, piuttosto umido, ma ben drenato. Le Clematidi rampicanti dovrebbero avere la parte aerea esposta al pieno sole del mattino, mentre la base del fusto protetta dall’ombra. Tutte le Clematidi resistono bene a temperature minime invernali che scendono anche di diversi gradi sotto lo zero. Poiché le Clematidi amano un clima abbastanza umido, dalla primavera all’autunno è indispensabile annaffiare il terreno attorno ai loro piedi con regolarità. Dopo la fioritura, le Clematidi rampicanti non richiedono una vera e propria potatura, piuttosto una regolare ripulitura dai rami secchi o rovinati dal freddo. Non tutte le Clematis si potano nello stesso periodo. In genere, vanno potate a fine inverno. In primavera nuovi germogli nasceranno dalle gemme presenti sui fusti. Le piante contengono varie sostanze: alcaloidi, anemonina e, in particolare, la saponina, che le rendono velenose. Questa pericolosa miscela di sostanze procura gravi irritazioni cutanee. Pianta molto amata nel Medioevo per non finire sul rogo delle streghe nella così detta età della Ragione! In fitoterapia, un tempo erano usate le foglie fresche in cataplasmi quale rimedio contro artriti, sciatiche e contusioni, ed essiccate con proprietà diuretiche e depurative. Anticamente, nella cura della scabbia si usava l’olio ricavato dalla macerazione delle foglie ma, a contatto della pelle, provocava fastidiose ulcere. Una volta era usato dai mendicanti per procurarsi delle dolorose ferite in modo da impietosire i passanti e indurli all’elargizione dell’elemosina, onde il nome popolare di ”erba dei cenciosi”. Se ingerite, le foglie rappresentano una potente tossina che agisce sul cuore.Oggi l’impiego di questa pianta in campo erboristico è stato completamente sostituito da piante con le stesse proprietà, ma con minori controindicazioni. In cucina si possono fare deliziose frittelle. I teneri germogli possono essere cotti e conditi con sale, olio, aceto e aglio, oppure cucinati a frittata. Le Clematidi che oggi crescono nei nostri giardini, che più nessuno usa per preparare frittate e per curare le ferite, sono soltanto ammirate per la loro bellezza ed eleganza. I rami della pianta, privati delle foglie, raccolti nel periodo autunnale e sfruttando la loro flessibilità, in passato erano usati per intrecciare panieri, cesti, coroncine. I fusti secchi erano usati come sigari che provocavano infiammazioni alle mucose della bocca e della gola. Le Clematidi hanno alcuni nemici naturali: le lumache che si nutrono dei germogli giovani. Le strisce argentee di muco indicano il passaggio o la loro permanenza sulla pianta. La Forbicina è un parassita tipico delle Clematidi e attacca i fiori. E’, comunque, considerato “insetto utile” perchè si nutre anche delle uova di altri parassiti. Altre malattie sono: il seccume, che comporta l’appassimento e la morte dei germogli, e il mal bianco, che si manifesta come una muffa biancastra sui fiori e sulle foglie.Nel linguaggio dei fiori, la Clematis indica “intelligenza limpida, onestà e bellezza interiore”. E’ il fiore adatto a chi sogna ad occhi aperti, a chi vive tra le nuvole, tra fantasie personali, a chi spera in un futuro migliore rispetto al realtà presente.
Il frutto è composto da numerosi acheni sormontati da un’appendice piumosa per favorire la disseminazione. Ogni frutto ha un solo seme. La riproduzione avviene per semina, per talea e per propaggine. La pianta di Clematide necessita di un terreno ricco di humus, piuttosto umido, ma ben drenato. Le Clematidi rampicanti dovrebbero avere la parte aerea esposta al pieno sole del mattino, mentre la base del fusto protetta dall’ombra. Tutte le Clematidi resistono bene a temperature minime invernali che scendono anche di diversi gradi sotto lo zero. Poiché le Clematidi amano un clima abbastanza umido, dalla primavera all’autunno è indispensabile annaffiare il terreno attorno ai loro piedi con regolarità. Dopo la fioritura, le Clematidi rampicanti non richiedono una vera e propria potatura, piuttosto una regolare ripulitura dai rami secchi o rovinati dal freddo. Non tutte le Clematis si potano nello stesso periodo. In genere, vanno potate a fine inverno. In primavera nuovi germogli nasceranno dalle gemme presenti sui fusti. Le piante contengono varie sostanze: alcaloidi, anemonina e, in particolare, la saponina, che le rendono velenose. Questa pericolosa miscela di sostanze procura gravi irritazioni cutanee. Pianta molto amata nel Medioevo per non finire sul rogo delle streghe nella così detta età della Ragione! In fitoterapia, un tempo erano usate le foglie fresche in cataplasmi quale rimedio contro artriti, sciatiche e contusioni, ed essiccate con proprietà diuretiche e depurative. Anticamente, nella cura della scabbia si usava l’olio ricavato dalla macerazione delle foglie ma, a contatto della pelle, provocava fastidiose ulcere. Una volta era usato dai mendicanti per procurarsi delle dolorose ferite in modo da impietosire i passanti e indurli all’elargizione dell’elemosina, onde il nome popolare di ”erba dei cenciosi”. Se ingerite, le foglie rappresentano una potente tossina che agisce sul cuore.Oggi l’impiego di questa pianta in campo erboristico è stato completamente sostituito da piante con le stesse proprietà, ma con minori controindicazioni. In cucina si possono fare deliziose frittelle. I teneri germogli possono essere cotti e conditi con sale, olio, aceto e aglio, oppure cucinati a frittata. Le Clematidi che oggi crescono nei nostri giardini, che più nessuno usa per preparare frittate e per curare le ferite, sono soltanto ammirate per la loro bellezza ed eleganza. I rami della pianta, privati delle foglie, raccolti nel periodo autunnale e sfruttando la loro flessibilità, in passato erano usati per intrecciare panieri, cesti, coroncine. I fusti secchi erano usati come sigari che provocavano infiammazioni alle mucose della bocca e della gola. Le Clematidi hanno alcuni nemici naturali: le lumache che si nutrono dei germogli giovani. Le strisce argentee di muco indicano il passaggio o la loro permanenza sulla pianta. La Forbicina è un parassita tipico delle Clematidi e attacca i fiori. E’, comunque, considerato “insetto utile” perchè si nutre anche delle uova di altri parassiti. Altre malattie sono: il seccume, che comporta l’appassimento e la morte dei germogli, e il mal bianco, che si manifesta come una muffa biancastra sui fiori e sulle foglie.Nel linguaggio dei fiori, la Clematis indica “intelligenza limpida, onestà e bellezza interiore”. E’ il fiore adatto a chi sogna ad occhi aperti, a chi vive tra le nuvole, tra fantasie personali, a chi spera in un futuro migliore rispetto al realtà presente.